La francesista Grazia Bernasconi-Romano propone una chiave di lettura dello scrittore friburghese e ne auspica la pubblicazione in lingua italiana.

Il romanziere Jean-François Haas, nato nel 1952 a Courtaman, Fribourg, dove attualmente ancora vive, è stato insegnante di letteratura francese nei licei della città.
Opere di Jean-François Haas:
• Tu écriras mon nom sur les eaux, Paris, Seuil, 2019.
• Le testament d’Adam, Paris, Seuil, 2017.
• L’homme qui voulut acheter une ville, Paris, Seuil, 2016.
• Panthère noire dans un jardin, Paris, Seuil, 2014.
• Le chemin sauvage, Paris, Seuil, 2012.
• J’ai avancé comme la nuit vient, Paris, Seuil, 2010.
• Dans la gueule de la baleine guerre, Paris, Seuil, 2007.
Tu écriras mon nom sur les eaux (Seuil, Paris, 2019) costituisce la sua più recente pubblicazione. Un multi-romanzo, in cui le storie di diversi personaggi annodate dal destino, il percorso, la vita, la Storia, s’incontrano, vanno di pari passo in luoghi geografici diversi per poi procedere in parallelo o intrecciarsi negli stessi luoghi.
Sono i personaggi, gli esseri, che sono importanti, non i luoghi che in questo romanzo coprono comunque la carta geografica terrestre. Sono i loro gesti e al di la dei gesti i loro pensieri, i loro sentimenti. Cosa spinge le persone a muoversi, andare, correre, scappare, ruzzolare, andarsene, morire, se non i sentimenti degli uni verso gli altri. E, in questo perenne movimento, una la ricerca suprema, quella di sentirsi o di vivere fino in fondo la possibilità data dalla vita di essere figlio o madre, di essere figlio o padre. L’epoca invece sembra costituire una variabile, come il decoro o i costumi per attualizzare il nocciolo del messaggio. Anche la lingua, lo stile si adeguano al lettorato e Haas non resta indietro, anzi! La sua narrazione richiede una lettura computerizzata, finestre che si aprono e si richiudono senza posa in un labirinto infinito, un pensiero che si dipana in parole mentali senza quelle regole che i grammatici hanno cercato a un dato momento di fissare e purificare! Il lettore è costretto a sposare e a seguire il narratore nella sua particolare logica altrimenti deve ritornare sui suoi passi e rintracciarlo; dunque per cogliere il senso non sulla sintassi, ma soprattutto su echi, richiami, rotture e riprese, si baserà il narratore per portar il lettore ad attivare di continuo l’attenzione grazie a un lavoro mnemonico interno e esterno, orizzontale e verticale, che non gli permetterà di dimenticare, di smarrirsi; si aggrapperà al suo bagaglio culturale da una parte e dall’altra a quegli elementi del racconto che ritornano come una litania a punteggiare, come piccoli chiodi, ma essenziali o vitali e universali e che fino alla fine della saga familiare continueranno a costituire le pietre miliari della vasta cosmografia romanzata.
Traduzione di un passaggio del romanzo Tu écriras mon nom sur les eaux.
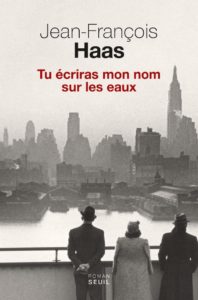 […] Nella scala oscura, un vago lucernario, un bagliore sudicio cadeva senza riuscire a illuminarla in quel buco in cui i tuoi occhi cercavano di vedere, ti fermavi a ogni porta, sfregando un fiammifero: camera 12? Terzo piano. Fra poco non ci avresti più visto un bel niente. C’era un interruttore per le probabili lampadine spente al soffitto? Un fiammifero. 12. I numeri ti sono balzati in pieno petto. Hai riletto attraverso le lacrime. 12. Qui. È qui. Diventavi un gemito. 12. Hai voluto bussare. La tua mano si ferma. Non sei qui, sei preso in un sogno che si burla di te. Svegliati. No. Senti una sedia scivolare sul pavimento. Qualcuno cammina. Lui cammina. Mio padre. Cammina, lì, dall’altro lato della porta. Bussa. Chiudi gli occhi: cancellare tutto il resto, cancellare il mondo e tutto ciò che è stato. Quando la porta si aprirà, li riaprirai, ti aprirai: lui, non ci sarà che lui, solo lui, lui per sempre. E, a poco a poco, attorno a lui, il mondo che ricomincia. Bussa. Il legno della porta ha rintoccato. Qualcuno – mio padre? – che si allontanava dalla porta – mio padre – si è fermato. Cambia direzione. Ritorna sui suoi passi. Si avvicina. A te. Sei notte. I passi esitano, si fermano, lì, proprio dietro quel legnaccio attraverso il quale si sente tutto. Un respiro. Respira. Respiri. Lì. Maniglia. S’abbassa. La porta. S’apre. Apri gli occhi. […]
[…] Nella scala oscura, un vago lucernario, un bagliore sudicio cadeva senza riuscire a illuminarla in quel buco in cui i tuoi occhi cercavano di vedere, ti fermavi a ogni porta, sfregando un fiammifero: camera 12? Terzo piano. Fra poco non ci avresti più visto un bel niente. C’era un interruttore per le probabili lampadine spente al soffitto? Un fiammifero. 12. I numeri ti sono balzati in pieno petto. Hai riletto attraverso le lacrime. 12. Qui. È qui. Diventavi un gemito. 12. Hai voluto bussare. La tua mano si ferma. Non sei qui, sei preso in un sogno che si burla di te. Svegliati. No. Senti una sedia scivolare sul pavimento. Qualcuno cammina. Lui cammina. Mio padre. Cammina, lì, dall’altro lato della porta. Bussa. Chiudi gli occhi: cancellare tutto il resto, cancellare il mondo e tutto ciò che è stato. Quando la porta si aprirà, li riaprirai, ti aprirai: lui, non ci sarà che lui, solo lui, lui per sempre. E, a poco a poco, attorno a lui, il mondo che ricomincia. Bussa. Il legno della porta ha rintoccato. Qualcuno – mio padre? – che si allontanava dalla porta – mio padre – si è fermato. Cambia direzione. Ritorna sui suoi passi. Si avvicina. A te. Sei notte. I passi esitano, si fermano, lì, proprio dietro quel legnaccio attraverso il quale si sente tutto. Un respiro. Respira. Respiri. Lì. Maniglia. S’abbassa. La porta. S’apre. Apri gli occhi. […]
L’intervista
Signor Jean-François Haas, Lei scrive per la Svizzera e per gli Svizzeri?
Vorrei dire che la scrittura è anzitutto un bisogno di essere, un bisogno di respirare spiritualmente. Respirare è aspirare: chiamare l’aria all’ interno di sé, ed è espirare: rimettere quell’aria in circolazione. C’è in me un bisogno di vita interiore e un bisogno di condividere quella vita con altri.
Scrivo per tutti, ma certamente in particolar modo per la Svizzera e per gli Svizzeri: amo il mio Paese, non sono nazionalista (un nazionalista si considera come il proprietario del suo Paese e non vuole aprirlo, condividerlo, riconoscere che, anche se si tratta di una terra particolare, una patria, la terra paterna e materna, non è che una parte della Terra che è data a tutta l’umanità. Secondo me, il mio Paese mi è necessario, come il pane, per viverne ma anche per condividerlo). Scrivo in quanto Svizzero, nato in un villaggio che ha visto arrivare centinaia di lavoratori italiani verso il 1960 con i quali abbiamo imparato a vivere di una vita nuova e non è stato tutti i giorni facile; ci vuole tempo per conoscersi, capirsi. È la mia Svizzera, è quella di cui parlo nei miei libri, e che vorrei lasciare in eredità alla Svizzera di domani, agli Svizzeri di domani. Non per dire: «Fate come me o come noi», ma «Lasciamoci interrogare da ciò che abbiamo vissuto». Ciò può forse aiutarci a avanzare fra le nostre ombre e permetterci di essere felici in Svizzera e felici di essere degli Svizzeri. Ma possiamo essere felici soli? Il Rodano, l’Inn, il Reno, il Ticino ci danno la loro acqua ma vanno a darla anche molto al di là delle nostre frontiere.
Le piacerebbe essere letta dai suoi compatrioti in francese – la sua lingua madre e quella dei suoi libri – oppure si contenterebbe di essere letta in traduzione (italiana, tedesca)?
Scrivo in francese e cerco di mettere nelle mie parole tutto ciò che fino a adesso ho appreso dalla vita. Una parola ha sempre una sorta di entroterra; da un punto di vista filologico, essa ha un’origine, un’etimologia, una storia. Ma non è tutto: essa si è fatta carico di umanità, di esperienze umane che hanno sviluppato il suo/suoi significato/i. E si è fatta carico della mia vita. Fra me e le parole, c’è una mutua fecondazione. Un traduttore si mette all’ascolto di queste parole, le fa abitare in parole che sono le sue. Il testo che ho scritto diventa in qualche modo un testo nuovo, che vive in una nuova lingua. Uno dei miei libri è stato tradotto in tedesco, un altro in romeno; diventano così come degli emigranti che vanno a vivere in una nuova lingua. Non sono dunque ostile alla traduzione; il traduttore non è un traditore, è un traghettatore che permette di traversare le montagne e i fiumi. Racconto delle storie e sono felice che si possano vivere queste storie anche in altre lingue. Senza le traduzioni non avrei mai potuto leggere degli autori che sono essenziali per me.
Prima di pubblicare le sue opere, lei ha insegnato la letteratura francese al liceo. Nei suoi corsi, ha parlato della letteratura romanda o francese della Svizzera ?
Sì, ogni anno. A ogni livello. Nelle classi di maturità e nelle classi della Scuola di Commercio. Ho fatto leggere dei romanzieri (Ramuz, sicuro, ma anche Jean-Pierre Monnier, Jean Vuillemier, Alice Rivaz, Yvette Z’graggen, Corinna Bille come letture di opere integrali e qualche altro sotto forma di estratti) come anche dei poeti (in particolare Philippe Jaccottet e Gustave Roud).
Quale statuto attribuisce lei alla letteratura svizzera (o letterature svizzere) nella società elvetica attuale o nel mondo attuale?
Svilupperò quello che ho già parzialmente detto qui sopra. Penso che la letteratura svizzera, nelle sue quattro lingue, alla quale bisogna aggiungere dei testi scritti nei dialetti e parlate locali, deve tener conto di ciò che siamo. Di conseguenza essa dovrebbe porre delle domande sulla Svizzera di oggi, anche sul nostro passato, da cui deriva l’avvento del presente. La memoria svizzera è infastidita da silenzi volontari, a volte imposti. Non mi vergogno di essere svizzero. Son fiero di ciò che abbiamo costruito nel corso dei secoli. Quando penso ai miei nonni e ai miei genitori, so ciò che vuol dire battersi per vivere in condizioni materiali difficili e assicurare un avvenire ai propri figli. Questa Svizzera della gente modesta, la amo, come amo la Svizzera degli inventori, degli artisti, degli architetti, degli scrittori. Ma dobbiamo avere il coraggio di guardarci tali e quali siamo, di guardare la nostra storia senza idealizzarla. Plinio Martini è, mi sembra, un buon esempio di ciò che cerco di formulare. Non si tratta di detestarci. Non è mai la persona né un gruppo di persone che bisogna detestare anche se non è mai facile; ogni essere umano ha diritto a uno sguardo d’amore. Ma il male che l’uomo che un gruppo di uomini può fare bisogna prenderne coscienza, affrontarlo, tentare di capire ciò che l’ha reso possibile per potercene liberare, affinché non continui e non possa rinascere. Questo ci conduce a portare il nostro sguardo non solo su di noi, gli Svizzeri, ma su di noi, gli esseri umani. Ciò detto, pretendo di essere un umanista, non un procuratore né un inquisitore. E condivido la visione dell’umanesimo del grande umanista lausannese André Bonnard che lo vedeva come uno stato di amicizia per l’uomo. È da lì che si dovrebbe cominciare a riflettere e a porsi delle domande.
Grazia Bernasconi-Romano
Il testo integrale dell'articolo è accessibile ai soli abbonati.
Effettui per cortesia l'accesso con i Suoi dati:
L'abbonamento per privati all'Osservatore costa CHF 35.--/anno
e può essere sottoscritto tramite
l'apposito formulario.
